Festival delle Colline Torinesi 2024
- Alessandro Bernardini
- 19 dic 2024
- Tempo di lettura: 22 min
Di seguito alcuni scorci sulla 28esima edizione del Festival delle Colline Torinesi svoltasi a Torino nel periodo 14 ottobre - 5 novembre 2024.
Il fuoco era la cura
ph Masiar Pasquali
Sotterraneo, compagnia teatrale originaria di Firenze, porta sul palco dell’Astra la sua nuova produzione, un adattamento libero del noto romanzo Fahrenheit 451 di Ray Bradbury, pubblicato nel 1953. In un futuro distopico in cui è vietato leggere, i pompieri sono incaricati di bruciare i libri nelle abitazioni segnalate. Il protagonista Montag, lui stesso un pompiere, è sposato con Mildred, una donna anaffettiva che trascorre compulsivamente la maggior del tempo a casa con il suo visore, incollata alle trasmissioni idiote dei “pagliacci bianchi”. L’incontro con la dissidente Clarissa incrina l’apatico incanto di Montag, che inizia a interessarsi dei libri. Faber, un ex professore dell’università, alimenta la sua curiosità, che si scontra con la fermezza autoritaria del capitano Beatty, incarnazione dell’oppressione del nuovo regime.
I cinque attori della compagnia si prestano a un racconto ben scandito, dove si intrecciano diversi mezzi espressivi. La scelta della musica, molto curata ma sempre troppo fulcro di una messinscena che ha ormai l’irrimediabile sapore del set cinematografico, è accompagnata, in alcuni punti, da spezzoni audio dell’omonimo film di Truffaut del 1966, sovrapposti alla recitazione in scena. L’ibridazione multimediale, caratteristica onnipresente di molte produzioni teatrali contemporanee, è qui al servizio di una rappresentazione immersiva del libro e al contempo di una sua formulazione critica. I due monitor sul palco offrono infatti delle frasi a sfondo sociologico dove il punto di vista dell’una viene contrapposto alla successiva sfidando il senso comune e presentando così una serie di antinomie volte a interrogare lo spettatore sui temi portanti del romanzo, quali la libertà, il controllo, l’informazione: «Perché rovinare la verità con una bella storia? Perché rovinare una bella storia con la verità?».
Il tempo narrativo della vicenda, che ripercorre i fatti del libro, si allaccia poi con alcune trovate interessanti. Gli attori si trovano a impersonare una compagnia che risponde alle tacite domande di un ipotetico pubblico, descrivendo la vita prima del nuovo sistema di governo. Qui emerge una forte riflessione sul rapporto menzogna/racconto, in quanto i monitor alternano alle risposte fornite un’istantanea dei fatti che le supportano, precisando l’ambiguità e la contraddizione dei personaggi; un carattere metateatrale e fortemente meditativo che si respira in altre scene della rappresentazione, come in quella del test nozionistico sulla repubblica italiana e quello sull’isolamento – studi dell’università della Virginia e di Harvard hanno mostrato come molte persone preferiscano autosomministrarsi da soli degli shock elettrici piuttosto che rimanere da soli in una stanza senza fare niente. Da quest’ultima, si può estrapolare quella che si rivela essere una caratteristica di buona parte dello spettacolo. Le azioni, infatti, risultano decisamente dilatate per le idee che vogliono comunicare, ovvero: la durata non aggiunge pathos, il dramma è scansato, andando a far lievitare un decorso dello spettacolo forse un po’ troppo lungo. Il respiro della regia si mostra estremamente concettuale e gli attori, per quanto efficaci, risultano semplici strumenti di una partitura cervellotica. La stessa ansia del cavillo, della specifica, si rintraccia in un’altra sfumatura precipua del tone of voice della contemporaneità teatrale, cioè l’utilizzo insistente dell’ironia. Un esempio innocuo è appunto sulla scenografia, dove si ironizza sulla correlazione tra la minimalità della stessa e lo scarso budget a disposizione. Per quanto lecito in un contesto dove si cerca di stemperare i toni di un narrato dalle tinte fosche – bisognerebbe però, in opportune sedi, domandarsi il profondo perché di questa necessità –, la sua invadenza si manifesta in un intervallarsi dell’azione scenica, frammentata in intermezzi strappati alla descrizione di un’alterità sottoposta all’attenzione continua del pubblico, un concentrarsi incessante su ciò che è assente, su quanto “dovrebbe essere”, piuttosto di sprigionarsi in una carica tensiva tuttora possibile. Le stesse partiture fisiche, infine, sono semplicemente spettacolarizzanti, non incarnando una pressante intenzione drammaturgica, e risultando prettamente “orpellesche”. Un riferimento, per esempio, è alla scena della danza intorno al fuoco dei guardiani dei libri (coloro che ne tramandano il ricordo imparandoli a memoria), tra i quali Montag si rifugia dopo essersi ribellato e aver ucciso il capitano e con cui si incamminerà verso la città dopo lo scoppio di un ordigno nucleare per prestare soccorso ai sopravvissuti: delle immagini passatempo, che stonano rispetto al mood molto di parola del resto della rappresentazione.
In sostanza, Il fuoco era la cura si rivela un prodotto ben congegnato, capace di soddisfare lo spettatore medio, stimolando una riflessione attuale e doverosa, anche se ostinatamente macchiata da quel tono apocalittico che serpeggia nelle coscienze artistiche di molte produzioni odierne: l’angoscia del crinale della storia. Il dover dire qualcosa dinnanzi alla supposta e imminente catastrofe – che qui ha il merito di non ridursi nel comiziesco e di mantenersi sottilmente bipartisan, ovvero lontana da una facile polarizzazione nella dialettica tra le dicotomie (libertà/sorveglianza, ambientalismo/negazionismo, ecc) – si scontra con una realizzazione che, per chi è in cerca di un teatro venato da lampi di autentico giubilo per le viscere, si conferma così avanzato nei tecnicismi del sensoriale da dimenticarsi la sensibilità della tecnica.
Cenci
ph Andrea Macchia
Giorgia Cerruti e la Piccola Compagnia della Magnolia portano al Gobetti la storia di Beatrice Cenci e della sua famiglia, una delle più ricche e importanti casate della Roma di fine Cinquecento. Francesco Cenci, padre di Beatrice, è un uomo depravato, noto per la sua avarizia e i molti vizi. Padre di dodici figli e sposato in seconde nozze con la nobildonna Lucrezia Petroni, qui impersonata dalla stessa Cerruti, rese la vita di Beatrice e del resto della sua famiglia una costellazione di violenze e soprusi. Rinchiusa nella rocca di Petrella Salto insieme alla matrigna e ai fratelli minori, Beatrice tentò di evadere dalla sua penosa condizione scrivendo una lettera al papa, con la richiesta di poter essere convolata a nozze o di entrare in convento. Infine, esasperata dagli abusi paterni, decise di uccidere il padre con la complicità di Lucrezia, di due fratelli minori e di due inservienti della tenuta. Al termine di plurime inchieste successive, i congiurati furono imprigionati e giustiziati l’11 settembre 1599 a Castel Sant’Angelo a Roma, in un’esecuzione a cui assistettero il Caravaggio e la futura pittrice Artemisia Gentileschi con il padre Orazio. Per sua esplicita richiesta, le spoglie di Beatrice Cenci riposano ora a San Pietro in Montorio.
Ed è da qui, dalla sua tomba, che il lamento di una voce fuori campo avvia la rappresentazione, ispirata all’opera di Artaud, che ne fece un emblema del suo teatro della crudeltà, e ai precedenti lavori di Shelley e Stendhal. L’avvio, un crossover tra commedia dell’arte e il teatro balinese tanto caro al regista francese, spande nella sala un’atmosfera sinistra e farsesca, quasi a voler già imprimere alla vicenda tutto il carattere della gratuità che il male assume spesso nella storia, specialmente quella domestica. L’attenzione scivola subito sui costumi, all’insegna del colore del sangue, il rosso, e volti a creare una continuità sovratemporale alla brutalità del tema: se infatti Francesco Cenci mostra con le sue pellicce l’animalità dell’animo umano, Lucrezia e monsignor Orsino rispecchiano il fasto rispettivamente della società civile e della chiesa dei tempi; Beatrice invece rappresenta, con i suoi abiti contemporanei, l’incarnazione del sopruso, nei secoli sempre presente e attuale. Tra i personaggi spicca poi la figura di Tonino, personificazione giullaresca e tragicomica di Artaud, che regala alcune scene di grande potenza lirica, in grado di fare della parola oltre la lingua un elemento protagonista, dando così una finestra su una possibilità che avrebbe potuto essere esplorata con più forza. Sebbene gli attori siano infatti riusciti a rendere il giusto contorno tonale ed espressivo alla vicenda, bisognerebbe chiedersi quanto della lezione sulla cruauté artaudiana sia stata assimilata e qui coscientemente incanalata. Se è vero che la mimesi della violenza non è il punto – e però potrebbe essere un accento da rimarcare per l’intensità scenica su quanto segue – c’è da dire che il carattere spiazzante e acido della contraddizione tragica viene qui affrescato con tinte che tentano l’emozione senza sconvolgerla. Il grande nodo che stringe il male e i suoi gesti viene sfiorato maggiormente nella sua esteriorità circostanziale rispetto all’intimo erotismo che lo connatura (si pensi alla lezione di Genet): cosa significa punire un innocente? La figura di Francesco Cenci, a mio parere il vero protagonista dell’azione e storica e psicologica, rischia di essere ridimensionata in favore di un’attenzione assistenziale e spesso patetica nei confronti della vittima Beatrice, che, in quanto soggetto dialetticamente passivo del cuore del dramma, non può che essere un riflesso limitato del suo nucleo essenziale. Questo per dire che la figura di chi esercita e incarna il fondo oscuro dell'esistenza dietro la vicenda è il padre; e sembra un'occasione persa non averne sviscerato la complessità (anche fittizia) ed essersi un po' accontentati di una visione pietistica sulla figura abusata di lei. Cenci è il nome della famiglia, Cenci sono gli stracci… e gli stracci umani sono sia chi riceve sia chi esercita il male, perché il grande fatto del dolore è oltre la colpa, oltre la moralità.
Una nota in sordina sull’amplificazione vocale con microfono: a parte i lievi problemi tecnici occorsi e l’atmosfera straniante riprodotta, era davvero necessaria? Nel finale, su un sottofondo sonoro realizzato direttamente in scena con uno strumento simile a un theremin, gli attori ci donano la lettura, in italiano tardorinascimentale, dei documenti dell’epoca: le testimonianze e le deposizioni dei responsabili dell’omicidio. Gli attori, ora vestiti con maglie con riferimenti punk-anarchici, si rendono partecipi di un’azione che ambisce in chiara luce a riportare la generalità della vicenda ai giorni nostri – da notare anche la presenza, durante lo spettacolo, di un’altra nota politica, sintomo della tendenza facilonamente engagé già menzionata sopra. Viene voglia di chiedersi, però, se non sia una scelta che abbia più forza concettuale che propriamente drammaturgica: si voleva un’esaltazione del macabro, mostrare l’utilizzo spettacolare di uno strumento esotico oppure ancora lo straniamento in una lingua distante? Questo per dire che, anche senza questo concludersi, la messinscena avrebbe avuto una più esatta centratura che avrebbe restituito in modo più fedele l’essenza, cara a chi scrive, del teatro artaudiano: quell’universalità metafisica che, nel gesto d’effimera eternità da parte dell’attore in scena, si fa geroglifico di vita oltre il tempo fatalmente al riparo da ogni mediazione.
Lapis Lazuli
ph Penelopi Gerasimou, Elina Giounanli, Julian Mommert
Nella cornice delle fonderie Limone di Moncalieri, Euripides Laskaridis, performer, regista e filmaker greco, mette in scena uno spettacolo scoppiettante e fascinoso. In una scenografia estremamente composita e sfruttata con maestria, un’autentica wunderkammer di oggetti e costumi dispersa per il palco – quasi la stanza di giocattoli per dei bimbi alle prese col proprio stupore – si assiste a un’alternanza di quadri il cui protagonista è un lupo mannaro che insegue la sua principessa in un nottambulo viaggio tra fantasia e tenerezza, dove l’ambiente stesso (buio, alberi, uccelli), incarnato dagli attori, si anima ad arricchirne la traversata. Osserviamo la rappresentazione della lotta costante e contradditoria tra natura – la tale ferocia – e incontro con l’altro, descritta con un linguaggio denso di variazioni e pregno della delicatezza del sogno, del fanciullo incantato dalla propria meraviglia. Il corredo sonoro, ricco e meticoloso sia negli accompagnamenti più lunghi sia nelle interpunzioni più minute che dialogano con le battute, si avvale di una mimica attoriale coinvolgente, di costumi elaborati e di un efficace utilizzo dei cambi tonali e delle voci, quasi vocalizzi tra il silenzio pregnante dei gesti. Nonostante alcuni momenti ripetitivi e un lento intermezzo tra le parti, dovuti verosimilmente alla complessità delle varianti sceniche quasi tutte completamente in chiaro, le giuste pause e l’uso sapiente dei tempi comici riescono infine a comunicare quella che sembra una gioia agrodolce per l’impasto confuso dell’esistenza.
Sullo stupore per le stelle, un male indistinto si incarna ed è subito sbeffeggiato, mostrato ridicolo. Il lupo si confronta col suo cacciatore psicologo, in un siparietto esilarante e familiare che intreccia la facilità della rabbia e l’invito tanto saggio quanto impossibile alla calma – respira, non ci pensare. Si vuole sedurre la principessa, ma le apparenze vengono sfidate: il docile garbo si rivela la maschera di una follia che spaventa l’impeto stesso del desiderio che lo tenta. Le parti lottano, si dimenano, veniamo interrogati in un’atmosfera burlesca e insieme vibrante. Di fronte al ballo di due amanti, ecco la solitudine che danza con lo scheletro della morte. La scena appare asfissiante, stretta sulla finzione, e da qui l’evasione che la sfonda: il lupo, quasi personificazione dello scarto tra immaginazione e realtà proprio della vita e dello stesso lavoro registico, è stufo dei personaggi, li irride, si logora per il poco contegno, per la troppa immedesimazione, regalando uno squarcio di consapevolezza: qual è il limite fugace degli elementi che accompagnano le nostre storie? E il gioco delle parti intravisto: quanto tastarne la miseria, come godersi l’inganno? Sul finale, una nascita dorata. Il protagonista, faraonico sacerdote di un rito necessario, è ora lupo tra i lupi e officia il contagio dell’altro in una genesi stravagante che ha il gusto di un sacrificio oscuro e la tinta scanzonata della surrealtà: forse l’esibizione di un rischio, quello dell’assimilazione narcisista, forse la constatazione dell’obliquità di una condizione esistenziale comune, quella della separazione e della disperata e beffarda ricerca di un appiglio fuori dal sé. All’ultimo, un ponte all’uditorio: «Non te ne andare, torna!». Il meglio deve ancora venire; ma un lamento in autotune, traboccante di malinconico tepore, rammenta al cuore un’aspra verità che scruta il pubblico come un’enigmatica e preziosa striatura d’azzurro: «What a beautiful beautiful show… what a difficult difficult life…». Il contrasto è servito, l’ululato lo accompagna oltre la platea, fin dentro la notte. Dove serve.
Ordalie
ph Marie Clauzade
Chrystèle Khodr, con la produzione del Théâtre des 13 vents di Montpellier, ci immerge in una riflessione sul potere e il tempo che ha come cornice la travagliata storia della sua patria, il Libano. Quattro attori, reduci dal fallimento politico dopo la guerra civile, si ritrovano in un setting oscuro a confrontarsi sul passato e il presente del loro paese, inframezzando i ricordi e le scaramucce personali con la rievocazione di scene di un loro vecchio spettacolo tratto da I pretendenti alla corona (1863) di Ibsen. In un’atmosfera dal sapore godottiano, in quella che sembra la notte dilatata e senza bordi di un’interzona allucinata, l’interazione interroga il tema delle rovine e il rapporto tra testimonianza e possibilità d’azione, insieme riscatto e redenzione: come interrompere il sankara di devastazione che abita quei luoghi?
Il dramma di Ibsen ripercorre la storia del medioevo del regno di Norvegia, il cui trono vacante è conteso tra Skule e Haakon: il primo è un nobile potente e ambizioso, che ritiene di aver diritto al trono in virtù della sua discendenza e del sostegno dell’aristocrazia; il secondo è invece un giovane carismatico che sostiene di essere il legittimo erede al trono, avendo dalla sua il diritto dinastico e l’avvallo della chiesa. L’opera illustra dunque la tragedia del potere, la sua natura distruttiva e gli inevitabili conflitti derivanti dalla sete che procura; pone poi l’accento sulla lotta interiore con il dubbio: Skule è infatti un personaggio scisso dalla sua incapacità di trovare una giustificazione morale alle sue ambizioni. Queste ultime, infine, si confrontano appunto con il tema della legittimità: fin dove la presunta purezza può infatti giustificare l’azione a discapito della legge? Una scena del dramma in particolare, riprodotta dai quattro attori, merita una menzione. Uno dei pretendenti chiede a un saggio se, avendo viaggiato molto, egli abbia mai incontrato una donna che amasse un figlio altrui. Questi risponde che è il caso delle donne sterili. Da qui una parabola che ci conduce in una meditazione sul ruolo della creazione poetica e della rivalità, facilmente traslabile sul piano dell’azione politica: è possibile uccidere un pensiero? Cosa succede ai pensieri di una persona uccisa? È possibile impadronirsene? La conclusione del sovrano è la seguente: sono una persona sterile perché bramo l’opera figlia di altri, di cui desidero l’annichilimento.
Lo spettacolo è una presa diretta su un unico incastrarsi di voci dei personaggi, tinte di malinconia e risentimento, che, con frizzante ironia e una sommessa lucidità, dipingono un panorama infausto della situazione esistenziale segnata dalla politica e dalla disillusione giovanile. Il ritmo, piuttosto lento, risulta difficile da penetrare, complice forse la distanza della lingua (l’arabo). Gli spezzoni della pièce rievocata sono accompagnati da un sottofondo musicale capace di orientare lo spettatore nella trama fitta dei dialoghi, utile escamotage che ha però l’effetto di donare all’architettura dell’insieme una rigidità che stereotipizza la già solida struttura di prosa. Questi lampi risultano infatti delle soste tematiche intorno a cui prova ad articolarsi, se pur disorganicamente, il filo metaforico della rappresentazione.
Ordalie si presenta dunque come un affaccio sul modo in cui il tempo che scorre accanto a una sofferenza condivisa incide i suoi solchi negli animi circostanti: speranze di una comunità, allergie identitarie, tentativi di sopravvivenza in un luogo dove l’ironia della sorte sembra non mancare mai il suo bersaglio. Un’opportunità piuttosto ordinaria, priva di torsione innovativa e troppo espansa, che stuzzica lentamente le meningi senza intaccare più in profondità. Il peso del dolore che fa poeti è soltanto indicato; dell’ordalia che lo realizza e ne trasmette l’infezione, nessuna traccia.
Sahara
ph Nicolò Gialain
Per inquadrare il lavoro diretto da Claudia Castellucci con la compagnia Mòra, qualcuno potrebbe utilizzare la semplice definizione di “noioso”, che è in fondo l’aggettivo più consono di un giudizio davvero sgombro e spassionato sull’argomento. Ma sarebbe ridurre la complessità critica che una tale opera merita di far emergere.
Sahara vorrebbe parlare di un deserto, «luogo di massima ombra», di una «povertà di materie e di relazioni che spinge la danza a considerare soltanto ciò che si ha: se stessi, come unico – primo e ultimo – strumento». Se è vero, come riportato nel foglio di sala, che «la mente non è un luogo esclusivamente proprio», la resa effettiva non sembra prestare a fede a questa dichiarazione, dimentica, piuttosto, del terreno comune che porge al pubblico la sostanza di un incontro. Sahara è uno spettacolo piatto, ripetitivo, senza dramma né azione, figuriamoci una spannung. Per quanto la prima scena possa far sperare una finezza estetica a venire, l’intera durata è percorsa da vuoti simulacri che, dietro la scelta stilistica della pacatezza di un ritmo fin troppo disteso (ma poi, tutta questa lentezza in un deserto? Qualcuno si è dimenticato le tempeste…), si rivelano come gesti inconsistenti, pose al servizio di concetti presunti ma indecifrabili, più esattamente inespressi. Le immagini costruite a suggerirne il senso non sono neanche sufficientemente belle per giustificare una tale mancanza di aderenza; e sembra inoltre che, accomunata negli intenti a tanta speranza di un teatro che ha obliato la voce abitata in favore di un cantiere di manichini e di giochi di lucette, basti solo l’audio, per la regia, a costruire un imbuto per l’attenzione – il tappeto sonoro era anche a tratti fastidioso, quasi un costante bagno di suoni ASMR. A proposito, si potrebbe menzionare un approccio alla musica che può dirsi mimetico. L’unità riportata tra questi due poli sembra infatti contraddire «la condizione temporale massimamente elastica» che un tale deserto dovrebbe riprodurre: se c’è, a quale fine poetico è canalizzata? L’antirappresentatività, infatti, sembrerebbe permettere invece quella dissociazione che più si adatta all’informe mutevolezza e polisemia che un tale paesaggio presuppone. Le poche intenzioni incarnate chiaramente nella drammaturgia appaiono prive di fondatezza, quasi ami gettati per stupire e privi d’esca, di ciccia, ovvero d’inganni: la maschera, l’inganno, per il sottoscritto è importante – e magari ci fosse qui un artificio! Da citare, ad esempio, la corda tirata a un certo punto tra platea e palco: uno dei pochi vettori d’alterazione che ci sono sul piattume generale, da leggere come una volontà che vorrebbe dare un twist alla dinamica scenica ma che rimane un qualcosa di totalmente superfluo, buttato lì, senza un perché né energia. In un’opera tendente al minimalismo, ogni variazione dovrebbe a maggior ragione assumere la portata che merita. Ma emerge, a tal proposito, una certa mancanza di cura, se non una certa supponenza: in molte pièce attuali, ritengo che dovrebbe essere tenuto più a mente che ciò che merita attenzione è quanto si sceglie di mostrare come figura e non come semplice sfondo. Il poco insomma, quando esiste, deve avere il guizzo del miraggio. La stessa parte parlata – l’unica dello spettacolo – sembra quasi il dovuto controcanto esplicativo volto a riempire il vuoto di concetto. «Il segreto e la memoria, la mossa del serpente», si ascoltano queste parole, della serie: lancio qualche enigmatico e suadente aforisma per ricordare che dietro a un infecondo visibilio risiede pur sempre una ricerca di spessore. Il tutto trasuda una ieraticità posticcia, dove i personaggi non inventano nessun rapporto tra di loro se non uno scialbo incastrarsi di spazi vacanti e membra smosse. Nessun vocabolario condiviso. Sembra di assistere a una comunissima lezione di teatro fisico priva però anche della minima scintilla tecnica. Gli attori, a voler essere onesto e dunque spietatamente insolente, risultano piuttosto delle figurine di una regia presuntuosa e arroccata nei suoi privilegi d’autore, ovvero una gioventù da macello per lavoretti collaterali da servire nel bel piatto di un festival; e da qui, si potrebbe aprire un capitolo sul ruolo che la “Castellucci e Associati” rivolge nel contesto del panorama italiano. Senza negare il valore di quanto merita tra le file della Socìetas (si pensi a Bros di qualche anno fa), l’impressione è che dal vivaio ultimamente escano fiori senza linfa e tuttavia preziosi, inghirlandati dalla placca del nome e finalizzati alla riproduzione di un sistema mercificato di cui c’è stata occasione di parlare già in altre sedi. Da qui la motivazione alla mia decisione di non assistere all’ultima performance presentata in rassegna, Senza Titolo, ovvero la scelta di dissociarmi dalla prosecuzione di un teatro fiacco alimentata dal blasone ai danni della visibilità di un talento emergente e diversamente – realmente? – sensazionale. Tutto Sahara, in fondo, potrebbe essere infatti riassunto nell’ipnotizzata dinamica di un «vediamo che succederà» piuttosto che in un «che figata quello che è successo!». E pensando al gesto dei soldi mostrati sulla scena tra gli sbadigli del pubblico in cerca di un’esclamazione, in quello sforzo incancrenito di trovare sempre un significato tra le righe che evidentemente non c’è , mi viene da sorridere – o, piuttosto, da urlare:«Ridatemeli indietro!».
Un’ora di quasi nulla, un ghirigoro sul niente. «Bisogna voler bene», scrisse Romain Gary.
L’ombelico dei limbi
ph Luca del Pia
Collegno. Stefania Tansini, già premio Ubu 2022 come miglior attrice under 35, regala al ristretto pubblico delle Lavanderie a Vapore una performance ispirata all’omonima opera giovanile di Antonin Artaud. La scelta di una messinscena pensata apposta per il luogo immerge il pubblico fin da subito in un clima singolare. Una pioggia disfatta di suoni accompagna l’apertura dei finestroni della sala, mentre il corpo della performer fa il suo ingresso e sperimenta le diverse dimensioni dello spazio, scarnificandolo, ovvero privandolo della sua pulsione umana e trasformandolo in luogo fantasmatico, equiparando l’incursione del corpo dentro di esso alla medesima invasione che la mente e il peso dello spirito riproducono nell’opera di Artaud, consegnata irrimediabilmente – e paradossalmente – a una catastrofe impersonale. Assistiamo infatti a un elegante e raffinata interpretazione gestuale del dramma confluito negli scritti del noto poeta francese, quello del conflitto tra mente e carne. Una duplice e contradditoria tensione anima gli spasmi della danzatrice, scissa tra frammentazione sensoriale e amalgama interna, lacerata da una spinta allo smembramento che sembra avere, come pungolo e sbocco inevitabile, quel desiderio di ritemprare un’unità sentita irrimediabilmente perduta: «Io non sono morto, sono separato». La libertà va scontrandosi continuamente con l’insostenibile “pesa-nervi”, il bagaglio organico dei pensieri, delle intenzioni, e delle incisioni che, con la forza dirompente di una fatale alterità, sembrano corrompere l’identità: ecco allora, nel corpo, una trama di reazioni scomposte ai suoi stessi gesti, quasi che questi fossero altrui e che l’occhio cercasse, in un voltarsi di sorpresa, le oscure membra che li animano. La performer prosegue questo tributo alla cedevolezza del riferimento (interno ed esterno) esponendo la relazione con le cose: prima conquista i gradoni della platea vuota di fronte al pubblico esplorando le consistenze metaforiche di un lenzuolo – occultamento e informità – poi accompagna il suo movimento verso una sedia, dove compie un simbolico rito di congiunzione. Del sangue blu cola sulla pelle: quale il dentro, quale il fuori? È il dolore fisico a completare, sublimandola, la sofferenza di un io tormentato da un’espropriazione continua della consapevolezza? È infine un indizio della nobiltà di uno stato di natura, insieme compito e fardello?
Non mancano le incursioni vocali. Una voce distante, asettica e abissale, scandisce un testo che allude, nella sua paraverbalità, al contenuto proclamato, ovvero l’innervazione delle cose nelle parole: come a voler dire che non è possibile proferire senza che il corpo detti il suo tremore. Infine, anche il discorso lascia i suoi lidi di senso per abbandonarsi a degli acuti che, condensando l’evasione disperata di una coscienza trafitta dalla propria ingombranza, regala agli astanti la sospensione glaciale di un silenzio. E infine il brivido.
Con la sua precisa eleganza e la dirompente presenza scenica che la caratterizza, la giovane coreografa piacentina si conferma, con questo lavoro, uno dei più fulgidi talenti della ricerca coreografica nostrana. È impossibile non domandarsi come un’occasione del genere sia stata confinata al weekend più caotico dell’autunno torinese – quello della settimana dell’arte – togliendo la possibilità, ai più pigri e meno informati, di godere di un simile tuono, lasciandoli con opzioni decisamente meno riguardevoli (vedi sopra). «Con me, l’assoluto o niente»: Stefania Tansini, in questo percorso chirurgico nei meandri dell’alienazione, realizza a pieno il testamento poetico che trasuda da parole così radicali.
La notte
ph Francesco Pullé
Pippo Delbono si cimenta con una riscrittura de La notte poco prima della foresta di Bernard-Marie Koltès, in scena alla Fondazione Merz. Il testo, apparso per la prima volta nel 1977, ha la forma di un soliloquio a cui il drammaturgo affida uno svisceramento delirante dei suoi temi portanti: l’amore, la politica e, più essenzialmente, l’incontro con l’altro. Un uomo – identificato come uno sconosciuto, uno straniero – si ritrova a incontrare un altro uomo e a domandargli una stanza per passare la notte, anzi: una parte della notte, giusto quella che gli servirebbe per smaltire la sbronza. Non c’è trama, quanto piuttosto un monologo il cui riferimento a un “tu” rimane sempre evaso, e che si costituisce di micro affreschi su situazioni trascorse: un’aggressione da parte di alcuni razzisti, una notte d’amore con un altro personaggio non meglio inquadrato, e tutta una sequela di storie che mettono in risalto l’oppressione della società sul protagonista e, verosimilmente, sull’autore stesso.
Delbono allaccia la sua personale rifrazione a questo riflesso. Lo vediamo sul palco trascinarsi affaticato verso la sedia di fronte al leggio e inaugurare questo viaggio, accompagnato dalla chitarra di Piero Corso, con una lettera del fratello di Koltès, che gli comunica il profondo senso di impotente dispiacere di fronte alla disgrazia dei naufragi nello Stretto di Sicilia. A partire da qui, dalla figura per antonomasia dello straniero del 21esimo secolo, Delbono si lancia in una modulazione intensa e rabbiosa sul dramma della non accettazione, dell’inconciliabilità che scaturisce dalla paura e del disperato assalto della solitudine verso i bastioni dell’esclusione: «Fammi accendere, coompaaaaagno!». Una richiesta che è in fondo un reclamo allegorico di calore, di luce, di vicinanza, e in cui si mescolano il risentimento per le istituzioni e la provocatoria risposta degli ultimi invisibili: l’aspra risposta di chi, scontrandosi con l’assurdità dell’indigeribile, sceglie la via dell’abiezione come fuga e vanto d’integrità. Da citare a proposito, l’immagine che dà il contesto al titolo originale: quel generale (soldato concreto e metaforico) che, appostato sul limitare della foresta, spara a tutto ciò che non ha il colore degli alberi.
Il risultato è uno straziante resoconto di una diversità imprigionata alla ricerca della sua singolare forma di resistenza – nella lettera di chiusura, scritta da Bernard alla madre che gli rimproverava la sua ossessione per la sessualità, egli oppone il proprio inconsueto concetto d’amore come chiave definitiva di lotta. A essere onesti, però, non si possono non appuntare, alla ricchezza dell’opera originale, i limiti della trasposizione del regista ligure. In primis, la durata: quasi due ore, qualcuno è anche uscito a buon motivo dalla sala. Ma questa non sarebbe un problema se la variazione drammaturgica (qui esclusivamente consegnata al registro tonale dell’attore/lettore e all’anonimo accompagnamento musicale fin troppo di contorno) non schiacciasse l’efficacia del testo in una ripetizione di stilemi vocali incancreniti, riconducibili a quelli dell’ubriacone e del vecchio brontolone pieno di bile. Delbono, è doveroso dirlo, appare consunto – è nota la malattia dell’artista, che lo accomuna al drammaturgo francese. Ed è quella stanchezza che mi fa esclamare con garbo e rispettosa stizza: «Spazio, aria, nuova pioggia su altre mani sconosciute: liberate la stanza!». Lungi dal concludere che la malattia debba essere allontanata dall’arte, costituendone invece un elemento fondamentale sia nella produzione che nella fruizione. Ma la domanda resta: invece dell’ennesimo tributo mediocre di uno dei grandi del nostro teatro, perché non sforzarsi di trovare qualcosa di più fresco e lodevole? L’affettazione di Delbono, simultanea a un’energia comunque sbalorditiva per le apparenze, è stemperata dalla serenità di un chi che ha già detto e fatto, e si permette, con vibrante e lucida veracità, il traboccare di un sentimento autentico, la possibilità di dirsi affini e confini nel tempo.
Il fuoco e la cura - Sotterraneo
creazione Sotterraneo
ideazione e regia Sara Bonaventura, Claudio Cirri, Daniele Villa
con Flavia Comi, Davide Fasano, Fabio Mascagni, Radu Murarasu, Cristiana Tramparulo
scrittura Daniele Villa
luci Marco Santambrogio
abiti di scena Ettore Lombardi
suoni Simone Arganini
coreografie Giulio Santolini
oggetti di scena Eva Sgrò
tecnica Monica Bosso
produzione Teatro Metastasio di Prato, Sotterraneo, Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa, Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale
con il sostegno di Centrale Fies / Passo Nord
residenze artistiche Centro di Residenza della Toscana (Fondazione Armunia Castiglioncello – CapoTrave/Kilowatt Sansepolcro), La Corte Ospitale, Centrale Fies / Passo Nord
Cenci - Giorgia Cerruti
scrittura e regia Giorgia Cerruti
regia Giorgia Cerruti
regista assistente Alessia Donadio
con Davide Giglio, Francesca Ziggiotti, Francesco Pennacchia, Giorgia Cerruti
visual concept, disegno luci Lucio Diana
composizione, sound design e fonica Guglielmo Diana
maschere Lucio Diana, Adriana Zamboni
costumista Serena Trevisi Marceddu
realizzazione costumi Daniela Rostirolla
danza storica Monica Rosolen
tecnico luci Francesco Venturino
organizzazione Emanuela Faiazza
uno spettacolo di Piccola Compagnia della Magnolia
in coproduzione con Teatro Nazionale di Torino, CTB Centro Teatrale Bresciano, Sardegna Teatro, Scarti-Centro di Produzione, con il sostegno di Teatro Akropolis, in collaborazione con I.I.C. Istituto Italiano di Cultura di Marsiglia e Fundacja Teatr Wschodni/Lublino / Boarding Pass Plus Project
Lapis Lazuli - Euripides Laskaridis
ideato e diretto da Euripides Laskaridis
con Angelos Alafogiannis, Maria Bregianni, Eftychia Stefanou, Euripides Laskaridis, Dimitris Matsoukas, Spyros Ntogas
musiche originali Giorgos Poulios
consulente alla drammaturgia Alexandros Mistriotis
scenografia Sotiris Melanos
luci Stefanos Droussiotis
effetti sonori Yorgos Stenos
costumi Christos Delidimos, Alegia Papageorgiou
oggetti di scena Konstantinos Chaldaios
consulente alla scenografia Vagelis Xenodochidis
consulente movimenti Nikos Dragonas
assistenti alla regia Charikleia Petraki & Yannis Savouidakis
direttrice del tour Marianna Kavallieratos
collaboratori artistici Telis Tellakis, Onassis AiR Fellowship 2022 research, Aggelos Mentis, Loukas Bakas, Filanthi Bougatsou
direttore tecnico Konstantinos Margkas
assistente al suono Martha Kapazoglou, Giorgos Chanos, Kostis Pavlopoulos
assistente alle luci Giorgos Ierapetritis
assistenti oggetti di scena Timothy Laskaratos
assistenti Nikos Charalampidis, Theologos Kampouris, Lida Manousou Alexiou
assistente alla regia Katerina Tsolou
scenografie Konstantinos Papantonis
oggetti di scena Aphrodite Psychouli, Ilektra Anichini Pantalaki, Efthymis Gronthos
costumi Ernesta Chatzilemonidou
drammaturgia Jimmy Machai
consulente alla regia Talya Rubin
luci Alexandra Drandaki
OSMOSIS coordinamento e comunicazione Euklida Velaj
tour management Polyplanity Productions / Yolanda Markopoulou, Vicky Strataki
fotografia Pinelopi Gerasimou, Elina Giounanli, Julian Mommert
fotografia e correzione del colore Nikos Nikolopoulos
trailer Euripides Laskaridis
un progetto di Euripides Laskaridis & the OSMOSIS performing arts company
produzione Onassis Stegi
con il supporto di Fondation d’entreprise Hermès
coproduzione Théâtre de la Ville, Théâtre de Liège, Espoo Theatre Finland, Teatros del Canal, Teatro della Pergola Firenze, Festival Aperto / Fondazione I Teatri Reggio Emilia, the Big Pulse Dance Alliance festivals: Julidans, Torinodanza Festival / Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale, One Dance Festival
cofinanziato dal Creative Europe Programme of the European Union
con il supporto di Megaron – the Athens Concert Hall
con il supporto del Ministero della Cultura Greco
grazie a Onassis AiR Fellowship
un ringraziamento speciale Dimitris Papaioannou & Tina Papanikolaou
si ringraziano Irad Avni, Rafailia Bampasidou, Antonia Economou, Doxa Glava, Santi Guillamon, Marianna Kavallieratos, Vicky Kaminari, Kali Kavvatha, Sylvia Liouliou, Vicky Maragkopoulou, Kostas Michopoulos, Drosos Skotis, Stelios Theodorou, Manolis Vitsaxakis, Papapostolou Orthopedics & Medical Supplies
Ordalie - Chrystèle Khodr
ideazione, drammaturgia e regia Chrystèle Khodr
liberamente ispirato a “I pretendenti alla corona” di Henrik Ibsen
con Rodrigue Sleiman, Roy Dib, Élie Njeim, Tarek Yaacoub
scene e luci Nadim Deaibes
suono Ziad Moukarzel
sovratitoli Georges Daaboul
produzione Théâtre des 13 vents CDN Montpellier
co-produzione Théâtre Garonne scène européenne – Toulouse, Théâtre Nanterre – Amandiers – Centre dramatique national, La Comédie, Centre dramatique national de Reims, Scène Nationale d’Albi – Tarn
con il sostegno di La Chartreuse Villeneuve-lez-Avignon – CNES – Programme NAFAS – Association des Centres culturels de rencontre (ACCR) du Ministère de la Culture, Printemps des Comédiens dans le cadre du Warmup
Sahara - Compagnia Mòra
danza della Compagnia Mòra diretta da Claudia Castellucci
con Sissj Bassani, Silvia Ciancimino Guillermo de Cabanyes, René Ramos, Francesca Siracusa, Pier Paolo Zimmerman
coreografia Claudia Castellucci
musica Stefano Bartolini
autore delle Luci Andrea Sanson
abiti Woojun Jang
tecnica Francesca Di Serio
direzione alla produzione Benedetta Briglia
assistente alla produzione Valeria Farima
amministrazione Michela Medri, Elisa Bruno, Simona Barducci
produzione Societas, Cesena
co-produzione TPE – Teatro Piemonte Europa / Festival delle Colline Torinesi
con il sostegno di UBI Unione Buddhista Italiana, Triennale Milano Teatro
L'ombelico dei limbi - Stefania Tansini
progetto, coreografia, danza, costumi Stefania Tansini
musica Paolo Aralla
luci Elena Gui
dramaturg Raffaella Colombo
tutor Silvia Rampelli
cura vocale Monica Demuru
assistente ai costumi Chiara Sommariva
organizzazione e promozione Federica Parisi
grazie a MeArTe_ tessuti e sartoria
grazie a MeArTe_ fabrics and tailoring
in co-produzione con Fondazione Teatro Grande di Brescia, Romaeuropa Festival, Tpe-Teatro Piemonte Europa/Colline Torinesi, Nanou associazione culturale
con il supporto di Residenza artisti nei Territori Masque Teatro, Boarding Pass Plus Dance/Santarcangelo dei Teatri, Olinda residenza artistica, residenza da Centro nazionale di produzione della danza Virgilio Sieni, progetto Air_Artisti in residenza 2023/Lavanderia a Vapore
La notte - Pippo Delbono
uno spettacolo-concerto di Pippo Delbono
da “La nuit juste avant les forêts” di Bernard-Marie Koltès
con Pippo Delbono
musiche Piero Corso
produzione Compagnia Pippo Delbono, TPE – Teatro Piemonte Europa, Festival delle Colline Torinesi

























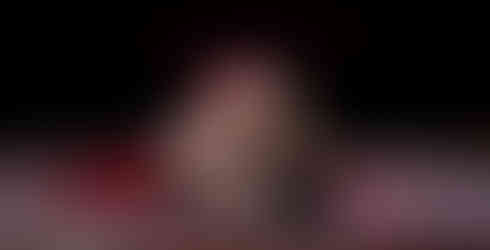





















































Commenti